Approfondimenti · 15 Febbraio 2025
Come è cambiato il senso della storia nel tempo presente. Conversazione con Francesco Benigno
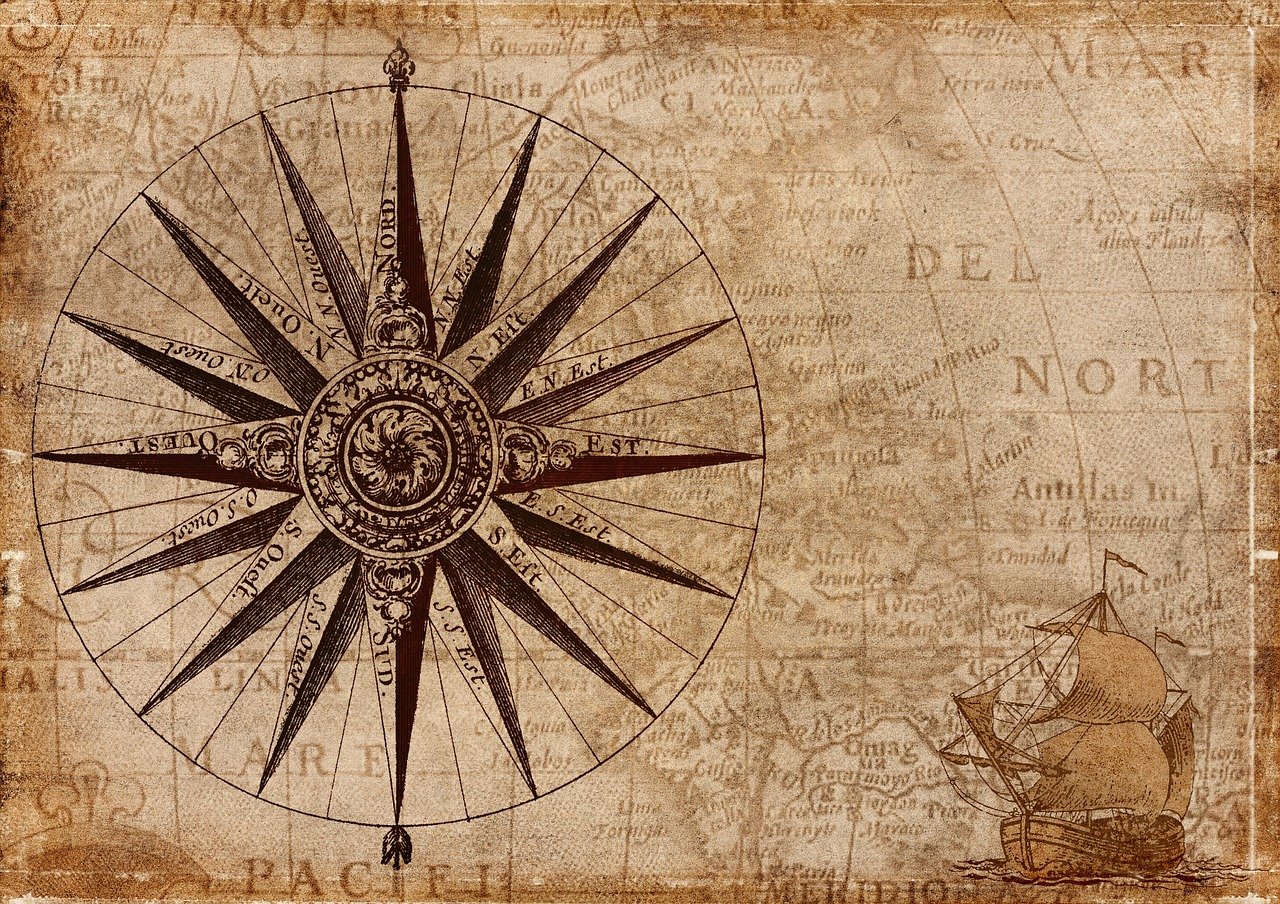
Qual è il modo migliore per studiare il passato, affrontandone tutti gli aspetti complessi e le possibili contraddizioni, senza cedere alla tentazione di cercare solo quello che ci fa comodo nel presente?
Francesco Benigno si occupa di storia moderna ed è uno degli studiosi italiani più noti e apprezzati. Insegna alla Normale di Pisa, è stato finalista a Friuli Storia e ha da poco pubblicato, per il Mulino, il libro La storia al tempo dell’oggi.
Secondo Benigno, le grandi crisi attuali – come quella climatica, la pandemia o le guerre – hanno diffuso un senso generale di incertezza. È come se la storia avesse perso la sua direzione verso una progressiva civilizzazione.
Il risultato è che abbiamo perso il senso della storia, rifugiandoci in un’eterna memoria che parte dal presente. Il rischio è così di perdere anche il senso di complessità, che invece dà senso allo studio del passato.
Di tutto questo Benigno ha parlato, in questa intervista esclusiva per il Circolo della Storia, con Andrea Zannini, che insegna Storia dell’Europa all’Università di Udine.
Registrati al Circolo della Storia e non perderti più alcun contenuto!
Hai letto 3 articoli: registrati al Circolo della Storia per continuare a leggere i contenuti di approfondimento dedicati agli iscritti.
Questa intervista viene pubblicata subito dopo il giorno della memoria (27 gennaio) e quello del ricordo (10 febbraio), dunque in un periodo di commemorazioni, discorsi pubblici e orazioni ufficiali. Siamo nel pieno di quello che chiama «discorso memoriale» che ha ormai assunto un «carattere sacrale o liturgico». Perché, secondo lei, questa sostituzione della storia con la memoria è un segno dei nostri tempi?
Fino a qualche tempo fa la storia suscitava un coinvolgimento collettivo fatto non soltanto di partecipazione ma anche di una costruzione molto forte ed elevata di “discorsi”. Questo apparato, che costruiva la storia in funzione del presente, si è in qualche modo disgregato, e il rapporto con il presente viene ora mediato da ciò che ho chiamato «memoria storica». La memoria storica fa riferimento a temi, ma soprattutto a gruppi e a persone del tempo presente, che a partire da un’area problematica e tematica specifica ricostruiscono il passato in funzione di questo.
Tra questi due momenti, quello della storia e quello della memoria storica, c’è stato un cambiamento secondo me molto rilevante e il libro cerca di mettere a fuoco questo passaggio.
E ci torneremo nel corso dell’intervista. Non ha timore di affrontare il tema tradizionale sul senso della storia, cioè quello della possibile (o auspicabile) verità storica. È un tema che accompagna le discipline storiche dalla loro nascita, cioè da venticinque secoli circa. Mi sembra però che lei – forse per la prima volta in modo così consapevole – accusi gli storici di aver abbandonato un approccio realista ed oggettivista alla storia. Usa l’espressione «rinuncia del camice». Cosa intende?
Intendo che c’è uno smarrimento dovuto all’esaurirsi di questa visione progressiva che legava passato, presente e futuro. È come se passato e futuro si fossero in qualche modo scollegati dal presente.
Io propongo – in maniera credo moderata – di fare un discorso sulla verità storica.
È un discorso di metodo?
Sì, che deve esserci, però come punto di riferimento, quindi non in termini assoluti ma relativi. Senza di questo il rischio è che ogni identità del presente pretenda di costruirsi la storia che gli conviene.
Nel senso comune, ad esempio nella public history, funziona molto l’immagine dello storico come detective del passato. Una ventina d’anni fa, in un libro molto famoso, Carlo Ginzburg avvicinava la figura dello storico invece a quella del giudice, quanto meno nel lavoro sulle fonti. Mi sono fatto l’idea che non Le vada bene né l’uno né l’altro paragone… mi sbaglio?
Penso che lei abbia ragione. Per un versante l’idea dello storico-detective va colta; però bisogna anche avere presente che quella del detective è una figura sociale, che porta con sé, come dire, un mestiere e delle modalità operative, imposte da questa professione. Il limite del confronto sta lì: nella dimensione molto particolare di quel mestiere.
Dall’altra parte, anche avvicinare lo storico al giudice ha i suoi lati positivi: in comune hanno lo sguardo imparziale, il bisogno di una verità che prescinda dagli interessi delle parti. Il giudice però inserisce il suo lavoro in una base molto delimitata, quella giuridicamente definita, che non è l’unica base possibile. Gli storici sanno benissimo che non puoi studiare la storia solo attraverso i trattati di diritto, la storia va considerata attraverso tante altre cose. Gli storici hanno più spazio.
Quindi secondo lei se il giudice termina il suo lavoro con la sentenza, lo storico ha in qualche modo anche la possibilità di esprimere un parere personale finale, purché questo sia ben distinto dalle fonti su cui lo basa?
Certo che lo storico può, e per certi versi deve, esprimere una posizione personale, ma deve essere sempre condizionata dalle fonti che possiede. Si può ad esempio sostenere che effettivamente un individuo, chiamato Cristoforo Colombo, il giorno tale è arrivato con una nave in quel posto lì. Mentre è più complicato nel caso di Erik il Rosso, che pure in America ci andò (con tutta probabilità), ma non abbiamo una documentazione definitiva.
Gli storici non possono dire quello che non è provato: fa parte del nostro mestiere. Devono restare all’interno delle cose che hanno un fondamento in modo da permettere anche ad altri di andare a vedere le fonti e poter dire: non è così.
Per fortuna viviamo in paesi liberi, dove si può dire una cosa e il contrario. L’importante è che le interpretazioni rispondano a determinati requisiti. Quello che non è ammissibile è l’invenzione del passato, l’invenzione delle fonti o la falsificazione dei dati.
Forse il grande successo che la storia ha, anche a livello mediatico, è dovuto al registro della storia come “racconto”. Questo è sempre stato nell’armamentario degli storici, a fianco però della storia come “problema”. Non ha anche lei la sensazione che questa dimensione della “storia-problema” stia perdendo forza, rispetto al racconto, che corre il rischio di trasformare la storia in una forma letteraria?
Io non sono contrario alla capacità degli storici di utilizzare forme narrative, che permettano di avvicinare il pubblico. Sono poi molto favorevole che gli storici utilizzino anche i nuovi media. Il problema fondamentale, però, è che tutte queste forme della comunicazione non possono essere messe al posto di quella ricerca di problemi…
Se dovessi fare un bilancio del mio lavoro, io ho sempre inseguito problemi! Significa affrontare un punto di vista che è stato consolidato secondo certe modalità e provare a vedere come le fonti, i materiali ci permettano di vedere altre cose, che non sempre sono quelle raccontate. In questo sta secondo me l’aspetto entusiasmante del mestiere di storico.

Un’altra tendenza contemporanea che emerge nel suo libro è quella di ancorare la storia (leggo) “ad una nuova trimurti di stampo soggettivistico-identitario: quella della nazione, dell’etnia, del genere” (p. 143). Si tratta certamente di una sostituzione rispetto alle vecchie categorie (tra le quali non citi però la classe sociale).
Mentre l’idea che la nazione e l’etnia debbano essere legittimate dalla storia non è nuova, questo discorso sul genere mi sembra molto attuale. In che maniera il genere sta diventando un altro elemento caratterizzante, ma anche deviante, per la ricerca storica?
Ho cercato di mettere in evidenza come siano in atto dei cambiamenti nel modo di fare storia. Prendiamo il caso della razza. Negli Stati Uniti c’è oggi la fortissima tendenza a immaginare che le razze si possano fare ognuna la propria storia. Mi hanno raccontato dei colleghi di dipartimenti americani che quando parla un bianco dei neri, i neri presenti si girano dall’altra parte. Come dire: tu non puoi parlare dei neri, perché solo noi che siamo neri possiamo farlo.
Ora, tutto questo è a mio avviso molto problematico. Riguarda anche il concetto di nazione. Venendo meno quello schema progressivo-modernizzatore di cui si parlava prima, e nel quale le nazioni avevano un loro ruolo, in mancanza di quello le nazioni diventano un tutto. E anche nel genere, al di là della complessità teorica che ho cercato di valutare anche positivamente nel libro, ci può essere una deriva limitante, che costringe a guardare alla storia solo da quel punto di vista.
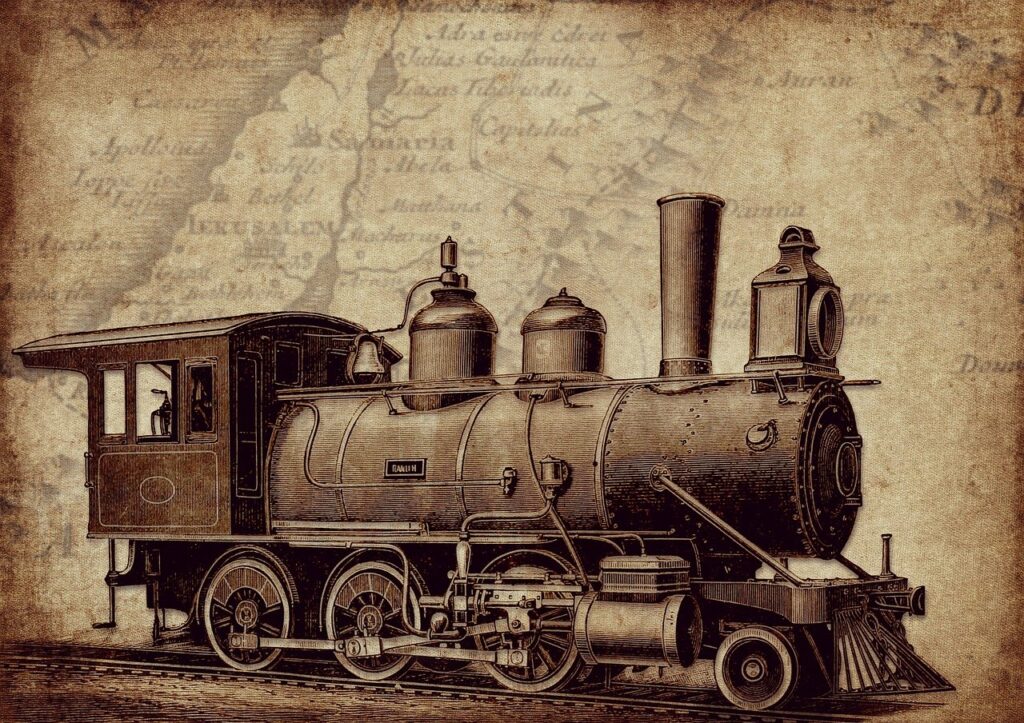
Arrivo solo alla fine al nucleo centrale del tuo libro. L’idea di fondo è che «la storia al tempo dell’oggi» segnali come siamo entrati in una fase nuova – non più moderna, bensì postmoderna – del tempo. Come si può descrivere sinteticamente questa nuova dimensione in cui stiamo vivendo?
È come se ieri tutti i fatti storici potessero essere compresi dentro schemi-categorie-processi di medio e di lungo periodo, che si proiettavano nel presente, arrivando persino ad ipotizzare un futuro possibile.
È come se questo schema fosse saltato. È come se noi non avessimo più una visione del progresso. Noi non pensiamo più che Donald Trump, tanto per dire, sia necessariamente un passo avanti della storia. Noi non pensiamo più che la pace sarà un processo crescente in tutto il mondo. Anzi, temiamo la guerra.
Noi temiamo anche cose che non dipendono dall’uomo, o che paiono sfuggire dal suo controllo come il cambiamento climatico oppure come le epidemie. Abbiamo un senso di incertezza che ha delle conseguenze sul modo in cui concepiamo la storia.
Non pensa che in questa attuale dimensione vi siano molti caratteri che gli storici modernisti sono abituati a trovare e a studiare nell’ancien régime?
Sì, sono d’accordo. Penso che nel momento in cui è caduta una certa visione dell’antico regime solamente come preconizzatore della modernità che iniziò da fine Seicento e con il Settecento, a questo punto l’antico regime può dirci ancora molte cose.
Anche per questo, ad esempio, quest’anno faccio un corso sulla cultura del barocco. Parlerò di quell’Europa italo-ispanicocentrica che ad un certo punto è stata disprezzata e messa ai margini dalla cultura vincente, che era quella francese. Un’Europa attaccata, prima che con la cultura, con le armi, nel 1684, quando i francesi bombardarono Genova perché alleata della Spagna.
Oggi a quel mondo che è stato a lungo disprezzato – compreso il barocco come arte visiva – potremmo tornare per porci delle domande e per porre a quel mondo domande che siano più significative. E che riguardano non uno degli aspetti di quella cultura, ma i tratti di fondo di quella cultura che ci possono risuonare nel mondo attuale.
Francesco Benigno, insegna Storia moderna nella Scuola Normale Superiore di Pisa. Si è occupato di politica europea e di rivoluzioni in antico regime, di crimine organizzato, terrorismo e pedofilia nell’età contemporanea. Tra i suoi libri recenti: Le parole del tempo. Un lessico per pensare la storia (Viella, 2013), La mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878 (Einaudi, 2015), Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica (Einaudi, 2018 – finalista a Friuli Storia), Rivoluzioni. Tra storia e storiografia (Officina Libraria, 2021)
© Riproduzione riservata