Approfondimenti · 6 Ottobre 2025
Un anno sotto l’occupazione: il Friuli e il Veneto tra Caporetto e Vittorio Veneto

Nel libro finalista a Friuli Storia, lo storico Gustavo Corni ricostruisce per la prima volta in modo organico la vita delle popolazioni veneto-friulane durante l’invasione austro-tedesca. Dall’esodo selettivo dei profughi alla fame diffusa, dalle responsabilità delle élite civili al ruolo del clero, un affresco inedito di un capitolo dimenticato della Grande Guerra
Con L’Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto (Gaspari, 2024), Gustavo Corni affronta uno dei nodi meno indagati della Prima guerra mondiale: l’anno di occupazione austro-tedesca che seguì alla disfatta di Caporetto e che segnò profondamente il Friuli e il Veneto orientale.
Per la prima volta, viene così ricostruito in un quadro organico le vicende di quei mesi, intrecciando fonti italiane, austriache e tedesche, testimonianze diaristiche e documenti d’archivio. Ne emerge un affresco inedito delle condizioni di vita sotto l’occupazione: esodi e deportazioni, requisizioni e fame, strategie di resistenza quotidiana, rapporti complessi con le autorità religiose e civili.
In questa intervista con Andrea Zannini, in vista della cerimonia di premiazione di Friuli Storia a Udine, Corni spiega perché la storiografia italiana ha a lungo trascurato il tema, chiarisce le dinamiche sociali e politiche di quell’esperienza e riflette sulle sue conseguenze nel dopoguerra.
Registrati al Circolo della Storia e non perderti più alcun contenuto!
Hai letto 3 articoli: registrati al Circolo della Storia per continuare a leggere i contenuti di approfondimento dedicati agli iscritti.
Il suo “L’Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto” è il primo studio completo sull’occupazione da parte degli eserciti degli Imperi centrali del Friuli e del Veneto orientale, tra novembre 1917 e ottobre 1918. Come mai questa trascuratezza da parte della storiografia italiana?
Mi sono sforzato di lavorare sulla scala più ampia possibile, dal livello degli archivi comunali e parrocchiali (molti non hanno conservato documenti su questo tema) agli archivi centrali, italiani, austriaci e germanici, incrociando le fonti di entrambe le parti dall’alto e dal basso. Che il tema sia stato trascurato dalla storiografia austriaca non sorprende, visto che sul Piave si è compiuto il crollo finale della monarchia.
Per quanto riguarda l’Italia i motivi di disinteresse da parte della “grande” storiografia possono essere due: da un lato il regime fascista, pronto a celebrare l’Italia e gli italiani “di Vittorio Veneto” e “del Piave”, non poteva valorizzare la remissiva sottomissione di una popolazione civile intera nei confronti dell’occupante. In secondo luogo, la componente che più di tutte si è impegnata per aiutare la popolazione civile è rappresentata dal clero locale. Di contro, una cospicua parte della classe dirigente civile (non tutta) ha abdicato alle proprie responsabilità.
Anche questo aspetto della vicenda ha probabilmente reso il tema poco appetibile, a livello di propaganda e di ricerca. Forte è stato invece, anche negli anni fra le due guerre, ma soprattutto negli ultimi decenni l’interesse della storiografia locale. Questa ha prodotto studi utili e pubblicato documenti e diari, che altrimenti sarebbero andati perduti.
Uno degli elementi che emerge dalla sua ricerca è che l’esodo degli italiani che fuggirono dall’occupazione, che interessò in tutto oltre 200 mila persone, fu “selettivo”. A tale proposito utilizza la formula molto suggestivo di una “Caporetto interna”. Cosa significa?
Per “Caporetto interna” intendo – come ho detto prima – il venir meno in quella drammatica congiuntura di una parte cospicua della classe dirigente laica – i “siori”- che ha avuto la possibilità di mettersi in salvo (maggiori informazioni, denaro, mezzi di trasporto) e lo ha fatto.
Certo, un atteggiamento comprensibile.
Lo leggiamo bene da un dato: dei circa 230 mila profughi oltre Piave più del 30% risultava risiedere in centri urbani, mentre sull’insieme della popolazione al censimento del 1911 i residenti delle città erano meno del 20%.
Moltissimi contadini sono rimasti attaccati al podere (piccolo, in genere), al bestiame, alla casa, alle scorte dell’annata agricola appena terminata. Su di loro si è scaricata la furia dei soldati, che nei primi mesi hanno saccheggiato tutto ciò che trovavano e compiuto ogni sorta di violenze e di ruberie anche nei mesi successivi.

L’invasione – una calata di austriaci, tedeschi, boemi, ungheresi, croati, bosniaci – assume, in molte delle testimonianze di prima mano riportate nel volume, i caratteri di una vera e propria invasione barbarica. A quale memoria storica venne ricollegata? Sarebbe rimasta come traccia psicologica nella popolazione veneto-friulana?
Il ricordo storico che è più presente nei diari è rappresentato dagli echi delle polemiche che nel 1914/15 hanno accompagnato i crimini compiuti dai tedeschi nel Belgio occupato e violato. Polemiche di cui anche una popolazione largamente rurale doveva aver risentito.
Ma non escluderei il riverbero di vicende più lontane. Si ha notizia di cerimonie di accoglienza dell’invasore, portando doni e fiori, che echeggiano vicende ben più remote: ai vincitori si debbono fare “ponti d’oro”.
Un caso particolare fu quello dei “profughi della linea del Piave”. Chi erano?
Ai primi di dicembre le autorità militari diedero l’ordine di evacuare la fascia rivierasca del Piave per una profondità di una decina di chilometri. Lì non dovevano più esserci insediamenti civili. I motivi erano di natura militare e di sicurezza. L’evacuazione avrebbe dovuto essere organizzata.
Nei fatti essa avvenne in gran fretta, nel caos e con mezzi di trasporto insufficienti e soprattutto senza aver organizzato forme di accoglienza dei profughi. Come quasi tutto ciò che venne attuato dagli austro-germanici nell’anno dell’invasione, c’era uno iato molto netto fra i piani e la loro attuazione.
I profughi del Piave – circa 40 mila – erano perlopiù donne, bambini e anziani. Furono così ricacciati verso Est a tappe forzate e costretti a vivere in condizioni molto difficili: non avevano dove stare, l’approvvigionamento era precario.
D’altra parte, arrivavano in territori in cui già mancava il necessario per gli abitanti locali. Ci sono stati casi di accoglienza generosa; in altri i profughi sono stati maltrattati e guardati con diffidenza. Abbiamo notizie che alcuni di loro abbiano vagato per mesi, inoltrandosi nel Friuli orientale per cercare una sistemazione. Del loro destino sappiamo poco o nulla.
Descrive l’occupazione austro-tedesca di queste terre come una strategia spietata da “tabula rasa”, per estrarre ogni possibile risorsa da un territorio che, peraltro, proveniva da due anni di guerra combattuta. Quale ruolo ebbero nel promuovere tale politica le drammatiche condizioni interne in cui ormai i due Imperi versavano?
Dobbiamo renderci conto che le condizioni materiali, soprattutto di approvvigionamento della popolazione dell’Impero erano sempre più difficili.
L’inverno 1917/18 fu contrassegnato dalla penuria di cibo, dagli scioperi e dalle proteste. La dirigenza imperiale diede ai comandi insediati nell’Italia occupata una direttiva ferrea: non potevano aspettarsi alcun rifornimento dalla madrepatria. Dovevano farcela con le risorse che trovavano sul territorio veneto-friulano; anzi, ne dovevano trarre possibilmente risorse da inviare in madrepatria.
In questa condizione di fondo, il quasi milione di soldati austro-ungarici non poteva fare altro che strappare ai civili tutte le risorse disponibili, riducendo al minimo le quote di cibo lasciate ai contadini e soprattutto agli abitanti dei centri urbani. Infatti, in totale assenza di un mercato gli abitanti rimasti nelle città non avevano di che procurarsi il cibo; le amministrazioni comunali provvisorie erano troppo deboli (nella maggior parte dei casi) per imporre ai contadini di consegnare quote di cibo.
Da parte loro i contadini, sottoposti alla diretta pressione dei soldati, combattevano una silenziosa lotta per nascondere le scorte alle incessanti requisizioni, spesso veri e propri furti legalizzati. Fallì anche il tentativo di lavorare i campi nella primavera-estate del 1918 in modo regolare, per poterne trarre un raccolto decente. L’esito finale di questa situazione è stata la fame, tremenda, per entrambe le parti: soldati e civili.

La reazione all’occupazione mise in luce molte delle debolezze che esistevano nella società italiana, dallo scollamento tra le classi sociali alla frattura strutturale tra città e campagne. L’unica componente della società che si salvò, secondo la sua ricerca, fu il clero, che rimase al fianco della popolazione occupata o dei profughi…
Sì, una parte consistente del clero in cura d’anime è rimasta sul posto. In collaborazione con spezzoni della classe dirigente laica (i casi di Udine e Feltre lo attestano) ha cercato di fare il possibile e l’impossibile – direi – per stabilizzare i rapporti con i comandi, per attenuare le requisizioni, per tenere un equilibrio fra città e contado sul delicatissimo tema delle forniture alimentari.
Ma non va dimenticato che il presule più importante nel territorio invaso, l’arcivescovo di Udine Anastasio Rossi, si è messo in salvo tempestivamente oltre Piave, o che il vescovo di Concordia-Portogruaro, Francesco Isola, a guerra finita ha subìto un tentativo di linciaggio ed è stato costretto ad abbandonare la sede vescovile accusato di avere speculato e di avere tenuto verso gli occupanti un atteggiamento che oggi definiremmo collaborazionista. Insomma, anche il clero non è indenne da critiche e – come sempre accade nelle vicende storiche – i toni di grigio e le sfumature prevalgono sui netti contrasti fra bianco e nero, fra buoni” e “cattivi”.
Tra i molti riflessi che l’anno di occupazione ebbe sulla società friulana e veneta del dopoguerra, qual è, a suo avviso, il più significativo?
A guerra finita le tensioni si erano accumulate e rinforzate a vicenda, facendo temere una rivolta sociale. I parlamentari della regione scrivevano al governo adombrando una “Irlanda veneta”. Si aggiunsero tensioni nuove: la difficoltà di ottenere i risarcimenti previsti per i danni subiti, un ciclo di aspre lotte sociali nelle campagne. Ma non avvenne nulla di eclatante. Il tema sarebbe da studiare con attenzione.
La mia sensazione è che fattori ed eventi molto più grandi – in primo luogo la rapida ascesa al potere del fascismo – abbiano radicalmente modificato l’agenda politica anche nei territori del Friuli e del Veneto, che avevano subito più direttamente i rigori della guerra, l’occupazione su tutti. Che insomma la “grande storia” abbia sovrastato quella “piccola”, come spesso accade.
Il libro
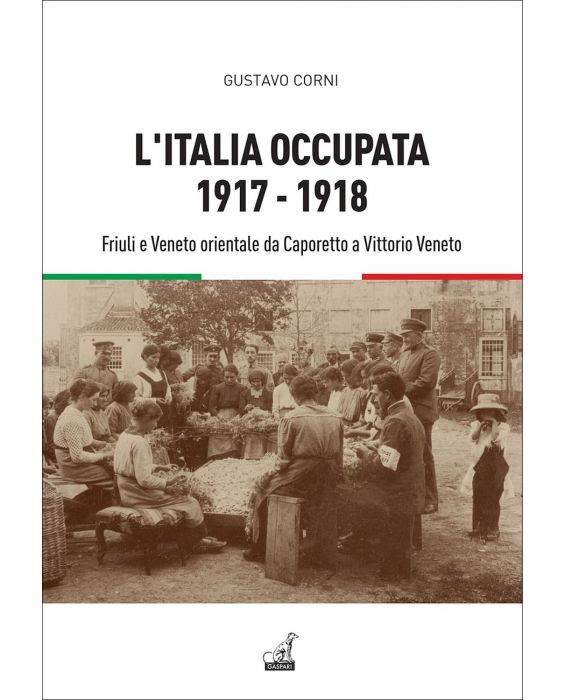
Gustavo Corni, L’Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto, Gaspari, 2024
GUSTAVO CORNI – già professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Trento, ha insegnato nelle Università di Venezia, Chieti e Trieste. È uno studioso di storia della Germania, delle dittature comparate e della storia sociale ed economica europea. Più volte borsista della Fondazione Alexander von Humboldt e nel 2008-2009 fellow del Freiburg Institute for Advanced Studies. Fra le pubblicazioni più recenti: Storia della Germania. Da Bismarck a Merkel (Il Saggiatore 2017); Weimar. La Germania dal 1918 al 1933 (Carocci 2020); Guglielmo II (Salerno, 2022).
